Intervista a Fabrizio Patriarca – “Tokyo transit”
Tokyo transit, romanzo di Fabrizio Patriarca, subito candidato al Premio Strega, è uscito per la casa editrice 66thand2nd ad ottobre 2016.
Sinossi
Alberto Roi e Thomas Asca si conoscono fin dai tempi dell’università. La loro è l’amicizia dei naufraghi, di chi è diventato maestro nell’ondeggiare senza risolversi. Ma in una Tokyo troppo nitida per poterne fraintendere la fine, e troppo disturbata per mettersi in salvo, c’è bisogno di appigli; anche solo per certificare d’essere persi. E allora Alberto si aggrappa a Motoko, dolente padrona di casa sull’orlo della vecchiezza e monaca delle inquietudini, mentre Thomas, dedito a un colto rapporto con la cocaina, si stordisce di lavoro portando a spasso turisti in astinenza d’emozioni. Accompagnando quattro businessmen americani nel gelo cauterizzato di una giornata di fine 2005, i due avviano la traduzione automatica di un viaggio che diventa transito, di una città che si fa confezione per le sue stigmate. Ne esce un’epopea caustica e bruciante, raccontata con una lingua iperbolica che abbatte a scudisciate i mulini a vento di una contemporaneità fieramente disperata. Perché i giapponesi, parafrasando Kafka, non sono altro che pensieri suicidi nella mente di Dio.
L’usura della lingua non esiste in questo originalissimo romanzo. Ostico a sfogliarlo solamente, Tokyo transit è tuttavia capace, approcciandolo invece con una buona dose di pazienza e dedizione, di ampliare il senso del linguaggio, di scavare nella profondità della psicologia dei personaggi, di raccontare la deviazione e il sentimento. Di parlare di un Giappone che non è che letterariamente non ci fosse, ma che è bello leggere così, nella sua nudità, nella sua poesia deviata e un po’ consunta.
 Corre rapida la storia, e si scende, si scende, ci si trasforma in voyeur che sbirciano e annusano, e sniffano cocaina, assistono ad amplessi, ascoltano pensieri, attraversano la città, si ritrovano tra gang, in compagnia di personaggi equivoci, alla lettura di un testamento, nella borghesia romana, e poi ancora a Roppongi, e poi Shinagawa…
Corre rapida la storia, e si scende, si scende, ci si trasforma in voyeur che sbirciano e annusano, e sniffano cocaina, assistono ad amplessi, ascoltano pensieri, attraversano la città, si ritrovano tra gang, in compagnia di personaggi equivoci, alla lettura di un testamento, nella borghesia romana, e poi ancora a Roppongi, e poi Shinagawa…
E così, dopo una perplessità iniziale dovuta ad un fermarsi frequente per via di termini inconsueti che farciscono le pagine del libro, ci si ricrede totalmente – io stessa l’ho trovato diverso, crescentemente, una volta avventuratami “seriamente” nella lettura.
Insomma, bisogna decidere di viaggiarci dentro a Tokyo transit, come capita a certi luoghi del mondo che presentano spazzatura ai lati delle strade, e miseria, ma che poi nei cumuli di immondizia notano la bellezza, una strana geometria capace poi di spiegare altri pezzi di mondo, profondamente diversi.
Non per stomaci delicati, né per puritani, Tokyo transit ti lascia addosso parecchio e ti insegna altrettanto. Il senso di alcune parole, per esempio. E ti fa entrare nella psicologia di gente da cui, se non leggi questo libro, normalmente vorresti tenerti alla larga. Perdendoti tuttavia un incontro.
Quello che sembrerebbe un romanzo crudissimo sul viaggio negli inferi – indi apparente, completamente negativa perdizione – dei due protagonisti occidentali, accompagnati dalla enigmatica Motoko – svela invece una notevolissima ironia. Si sorride dell’intelligenza, della parola colta che veicola una quotidianità spiccia, quella che di primo acchito potrebbe esser scambiata per volgarità.
E leggendo le risposte di Fabrizio Patriarca comprenderete quanto colto è questo libro, quanto uno sguardo davvero intelligente può svelare ancora del Giappone.
-
Come è nato questo libro? Da dove saltano fuori i personaggi di Tokyo transit? E soprattutto cosa ti ha divertito di più nello scriverlo?
Nel 2010 avevo preparato un saggio su Parise in Giappone per un numero monografico di «Nuovi Argomenti»: ero in uno strano periodo, perché cominciavo a sentire sempre più complicato il mio rapporto con l’università, soprattutto con quel tipo di scrittura “accademica” piena di nessi uniformi, espressioni omogeneizzate, passaggi obbligati: lo spazio su «Nuovi Argomenti» mi concedeva maggiore libertà – che poi la libertà autentica del saggista non è altro che infusione dell’esperienza biografica nel quadro della scrittura: non una forma di impressionismo, si tratta di riportare l’oggetto dell’indagine alle dimensioni di un’avventura personale. Questo mi ha un po’ liberato. Nel saggio avevo utilizzato una certa visione del Giappone per comprendere qualcosa di uno scrittore italiano. Allora mi è venuto in mente che si poteva estendere la faccenda: sono tornato nuovamente a Tokyo con l’idea di adoperare la città come uno strumento di “stress”. Mettiamo tutto alle corde, pensavo: un certo spirito italiano, una certa nozione del “viaggiare”, la mia stessa scrittura. In questo senso Tokyo, più che una Wunderkammer a uso del lettore, è la “camera della tortura” di un autore che si esercita con la nausea. Intorno al 2012 ho cominciato a lavorare su porzioni di testo: era chiaro che non potevo scrivere lungo una direttrice puramente intellettuale – per questo ho scelto la forma narrativa. Era altrettanto chiaro che dovevo comprimere i tempi della “tortura”, altrimenti sarebbe venuto fuori qualcosa di intollerabile, per me e per i lettori. Per questo la storia prende un giorno, un solo giorno, e acquista spessore attraverso i flashback. Mi sono chiesto che razza di personaggi avrei dovuto mettere in scena, e ho deciso di abbandonarmi alla vendetta: ecco allora un paio di intellettuali inespressi (Alberto) o “pentiti” (Thomas) – nel modo in cui ci si può pentire di un reato. Vivono il genere di esistenza che probabilmente avrei scelto io se l’università non mi avesse intrappolato, o meglio: se avessi avuto la forza di non lasciarmi intrappolare. Se li osservi, per come parlano, per quello che dicono, per le cose che gli girano in testa, ti accorgi che sono due otaku. Questo mi piaceva parecchio: che i veri otaku del libro non fossero personaggi giapponesi, ma i due personaggi stranieri. Sovverte un po’ le aspettative, e definisce bene il quoziente di “nipponizzazione” degli europei di una certa generazione. Poi c’è Motoko: per lei mi sono ispirato a una cordiale e inquietante signora giapponese che una sera mi ha invitato a cena nel suo appartamento di Shinagawa: parlava un ottimo inglese e ha preparato l’oyakodon, per il resto mi ha fatto una marea di domande sull’Italia, ma di sé non diceva quasi nulla. Come succede spesso con la narrativa, mi sono “divertito” a inventarmi il passato di questa donna. Avevo letto una versione inglese di Underground di Murakami che circolava in rete, e ho pensato che la mia Motoko potesse tranquillamente essere una delle voci raccolte da Murakami come testimonianza dell’attentato del ’95. Sai, girando per presentare Tokyo transit, ho scoperto che in Italia la memoria di quell’attentato è piuttosto sfocata – credo sia una faccenda che riguarda in generale il nostro rapporto con le notizie di drammi su vasta scala, e che nel libro ha un certo spazio: la facoltà di rimozione. Non ti nascondo che per me lavorare a un libro è una fatica bestiale: non sono uno di quelli, ahimè, baciati da una “felicità” dello scrivere, sono pieno di repulsioni, fissazioni, insofferenza per la lingua comune, quella pronto-consumo di tanto romanzo contemporaneo (il che, se ci pensi, non è così astruso, detto da uno che vive facendo l’editor e il ghost-writer di libri commerciali). Da piccolo ero il tipo di bambino che si torturava le gengive con lo stuzzicadenti, nella scrittura sono più o meno rimasto quel bambino – innocuo masochismo, però mi piacciono i libri che ti impegnano. Di recente ho sentito un amico scrittore dire una cosa meravigliosa: non c’è peggior torto che si può fare a un libro che proclamare «l’ho divorato». Ecco, io sto da quella parte lì. Mi faccio un dovere che il mio lettore abbia tutto l’agio di sostare a lungo nel paragrafo, rileggerlo, meditarlo. Il rischio, oggi come oggi, è di trovare un lettore riluttante. Fatti suoi, il lettori ha tutti i diritti del mondo, gli scrittori, per lo più, hanno pochi, ineludibili doveri. Tutte queste osservazioni per dire che forse il massimo del divertimento è nel non tradire se stessi – quando rileggi un paragrafo e vedi che è troppo scarico, che non gira come dovrebbe, non ti appartiene, e allora lo butti via senza alcuna pietà. Non mi sposto dall’infanzia: stuzzicadenti e gengive. Se penso al “gonfiore” tipico dei romanzi che mi piacciono non ho difficoltà a immaginarlo come l’esito di un’infiammazione – lavorare sulla lingua è tutto un molestare le parti sensibili finché non ottieni una reazione soddisfacente.

-
Scrittura accademica, scrittura narrativa. Da Leopardi a Inoki Antonio. Cosa è successo a Fabrizio Patriarca?
Fino a una certa altezza della sua carriera di personaggio pubblico (diciamo fino all’ingresso in politica) Leopardi avrebbe adorato Inoki. Ne avrebbe fatto l’icona di una gustosa pagina sociologica sul Giappone. Sì, il colosso di Yokohama non sfigurerebbe dentro lo Zibaldone: «s’io avessi la prestanza d’un Inoki…», anche se nei miei ricordi di adolescente la figura che si staglia di netto nell’immaginario è quella di Fujinami Tatsumi, un wrestler possente e acrobatico, insieme a un gineceo di lottatrici furibonde e aggraziate: Devil Masami, Jaguar Yokota e la mitologica Mimi Hagiwara, di cui ero estaticamente invaghito a dieci anni. Una passione effimera, perché poi mi sono innamorato di Nikka Costa, che aveva stregato il mondo cantando (Out here) On my own. Nikka Costa, tanto per dire, era nata a Tokyo, ed eravamo coetanei: con lei sentivo di avere qualche speranza. Vedo che tutto questo c’entra molto col Giappone e poco con la tua domanda, quindi vengo al punto. Non so se la scrittura accademica sia stata una distrazione, una distorsione o una divagazione rispetto a quella narrativa. So che ho sempre coltivato la narrativa senza mai praticarla seriamente prima dei quarant’anni. Se guardi il mio libro su Leopardi ti accorgerai che c’è dentro una ruminazione dei fenomeni retorici che poi diventa ironica in Tokyo transit (forse diventa ironica perché semplicemente prende un segno “attivo”) – però ogni capitolo ha un timbro decisamente “universitario”. Poi ho scritto un libro su Montale che è una specie di vademecum per iniziati, dove ho provato a tirare il collo alle possibilità della lingua ermeneutica: ne è venuto fuori un testo criptico, quasi surreale, a distanza di qualche anno mi sono reso conto che è una vera e propria parodia della scrittura accademica – nonostante gli intenti fossero serissimi. Prima di Tokyo transit c’è stata un autofiction che racconta gli anni dell’università, gli anni novanta che adesso – pare – sono tornati di moda. Quello è stato il libro del passaggio, il libro d’addio a un’esperienza durata vent’anni. Anche se non sono il tipo che riesce a chiudere completamente le proprie esperienze: ogni tanto vado ancora in facoltà, in macchina ascolto Domino dancing dei Pet Shop Boys e I’m not scared (feat. Patsy Kensit) come se fossero uscite ieri, mi lamento perché non posso più studiare come una volta. In Italia c’è sempre stato un dualismo fatto di personaggi scissi come accademici/narratori e accademici/poeti, c’è poi un dualismo insopportabile dei critici/poeti recensori/narratori. Per me ho scelto una soluzione drastica: abolire il dualismo. Non posso scrivere romanzi e occuparmi a tempo pieno dei romanzi degli altri – so che la seconda attività diventerebbe presto un ozioso palcoscenico dell’intelligenza, e dato che sento di non avere a disposizione quantità illimitate d’intelligenza preferisco riversarla dove mi preme di più. Ecco cosa mi è successo: sono diventato avaro, perché il tempo e le risorse scarseggiano, e non sai quanto mi costa ammetterlo.
-
Il modo in cui leggi è riflesso nel modo in cui scrivi? L’approccio analitico alla parola, il periodare stratificato che pare cercare nella frase qualcosa più di una immagine sola, un pezzo di trama: sono cose che vai cercando anche in quello che affronti da lettore/studioso?
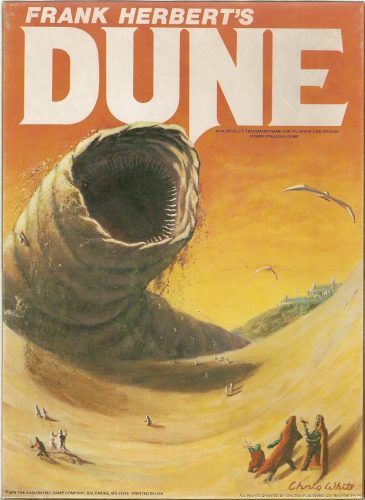 Quando sento parlare gli addetti ai lavori m’imbatto spesso in un concetto talmente abusato che ormai è diventato una specie di verità automatica che risponde da sé, senza più alcuna mediazione cerebrale: i cosiddetti “lettori professionali” hanno uno sguardo sterzato dal mestiere, hanno perduto l’innocenza di un tempo. In parte è vero, ma non credo si debba assumere come un fenomeno tipico solo degli addetti ai lavori. Con mio padre leggevamo e rileggevamo Dune di Frank Herbert: ho osservato negli anni come “virava” il suo sguardo di lettore non professionale, mentre contemporaneamente assistevo al viraggio del mio. È stato utile avere un banco di prova comune. Mio padre ha scoperto la tematica ecologica di quel libro molto tardi – lo intrigava di più il fronte mistico-religioso, di cui discutevamo spesso. Mi sembra che la tematica ecologica gliel’abbiano suggerita i tempi della sue ultime letture, quando il problema ambientale aveva ormai preso uno spazio stabile nella discussione pubblica. Dietro al nostro occhio sui libri c’è sempre l’occhio del mondo in cui viviamo, l’occhio dell’età, dell’umore, ecc. Guardiamo ai libri con occhi di mosca. La lettura per me è sempre stata un’esperienza catafratta, di scomposizione. Non credo nemmeno tanto alle teorie su una presunta “età dell’innocenza” rispetto ai libri che leggiamo. Voglio dire: scoprire Jane Austen a sedici anni passi, ma se ti capita come al sottoscritto di ritrovarti fra le mani a undici anni la copia di Emmanuelle lasciata in bagno da tua madre, scopri che l’innocenza nel senso della pura disposizione a lasciarsi avvincere dalla trama e dall’atmosfera di un libro è anch’essa illusione – un romanzo sbagliato può diventare, nelle mani giuste, un manuale per cavarsela nella vita o un banale propellente per la masturbazione. Immagina cosa può fare un libro giusto nelle mani sbagliate… Io sono stato fino all’università un lettore disordinato, guidato solo dall’intemperanza e da una serie sterminata di pregiudizi. Poi ho dovuto adeguarmi a una certa sistematicità, mantenendo fortunatamente intatto il gusto del collaterale, e sfrondando molti dei pregiudizi di cui sopra, però ho capito presto che la lettura era un’attività tutt’altro che innocente. Questa convinzione credo sia passata intera nel mio modo di scrivere: la consapevolezza dell’artificio, e per certi versi l’arroganza dell’artificio consapevole.
Quando sento parlare gli addetti ai lavori m’imbatto spesso in un concetto talmente abusato che ormai è diventato una specie di verità automatica che risponde da sé, senza più alcuna mediazione cerebrale: i cosiddetti “lettori professionali” hanno uno sguardo sterzato dal mestiere, hanno perduto l’innocenza di un tempo. In parte è vero, ma non credo si debba assumere come un fenomeno tipico solo degli addetti ai lavori. Con mio padre leggevamo e rileggevamo Dune di Frank Herbert: ho osservato negli anni come “virava” il suo sguardo di lettore non professionale, mentre contemporaneamente assistevo al viraggio del mio. È stato utile avere un banco di prova comune. Mio padre ha scoperto la tematica ecologica di quel libro molto tardi – lo intrigava di più il fronte mistico-religioso, di cui discutevamo spesso. Mi sembra che la tematica ecologica gliel’abbiano suggerita i tempi della sue ultime letture, quando il problema ambientale aveva ormai preso uno spazio stabile nella discussione pubblica. Dietro al nostro occhio sui libri c’è sempre l’occhio del mondo in cui viviamo, l’occhio dell’età, dell’umore, ecc. Guardiamo ai libri con occhi di mosca. La lettura per me è sempre stata un’esperienza catafratta, di scomposizione. Non credo nemmeno tanto alle teorie su una presunta “età dell’innocenza” rispetto ai libri che leggiamo. Voglio dire: scoprire Jane Austen a sedici anni passi, ma se ti capita come al sottoscritto di ritrovarti fra le mani a undici anni la copia di Emmanuelle lasciata in bagno da tua madre, scopri che l’innocenza nel senso della pura disposizione a lasciarsi avvincere dalla trama e dall’atmosfera di un libro è anch’essa illusione – un romanzo sbagliato può diventare, nelle mani giuste, un manuale per cavarsela nella vita o un banale propellente per la masturbazione. Immagina cosa può fare un libro giusto nelle mani sbagliate… Io sono stato fino all’università un lettore disordinato, guidato solo dall’intemperanza e da una serie sterminata di pregiudizi. Poi ho dovuto adeguarmi a una certa sistematicità, mantenendo fortunatamente intatto il gusto del collaterale, e sfrondando molti dei pregiudizi di cui sopra, però ho capito presto che la lettura era un’attività tutt’altro che innocente. Questa convinzione credo sia passata intera nel mio modo di scrivere: la consapevolezza dell’artificio, e per certi versi l’arroganza dell’artificio consapevole.
-
Di riferimenti letterari ve ne sono molti disseminati nel testo, altri più precisamente dichiarati sul fondo del libro, nel Glossario che più che spiegare impersonalmente certi vocaboli giapponesi, racconta piuttosto la cultura giapponese filtrata attraverso i tuoi occhi. Goffredo Parise, Roland Barthes, Murakami Ryū, la cultura pop che giunge coloratissima in occidente. Quali altri?
Per dire: quando ho scelto i nomi dei personaggi ho provato inizialmente una tecnica stile-Asimov: lui prendeva dei nomi comuni e sottraendo o aggiungendo qualche lettera li trasformava in nomi dalle sonorità aliene. poi ho tentato delle riscritture non troppo “sonanti” e scoperte: Thomas Asca e Alberto Roi derivano da Mattia Pascal e Adriano Meis, che nel romanzo di Pirandello sono la stessa persona. C’è poi tutta una serie di citazioni da Jurassic Park che non voglio svelare perché spero di averle nascoste per bene – anche se ho un amico spielberghiano che le ha beccate quasi tutte. Andrea Cortellessa, in una recensione su «Tuttolibri» ha rilevato una «brillantezza da forzato» alla Martin Amis, e ha colto nel segno. Amis è, almeno in un paio di libri, uno scrittore venerabile. Tuttavia non mi piace la citazione-omaggio, trovo che non abbia senso: quando scrivi un romanzo devi sentirti libero di trattare le costellazioni letterarie come tratti tutti gli altri oggetti che metti in scena. C’è una parte di gioco, nella citazione, da cui dipende molto del suo fascino, però bisogna saper giocare – i libri parlano fra loro, nella mia visione di “artificio consapevole” una citazione involontaria sarebbe intollerabile. Ho messo nel libro riferimenti a Star Wars e Star Trek, roba che i puristi dell’una e dell’altra sponda mi ucciderebbero, ma ero spinto dalla necessità: se devi rappresentare due personaggi europei “nipponizzati” non tanto per quello che pensano, ma per il modo tipicamente otaku in cui articolano ed esprimono la loro “enciclopedia personale”, ti ritrovi costretto a fare della citazione non un evento occasionale, ma la trama stessa di un pensiero. Motoko, in questo senso, è un personaggio molto più lineare, con lei ho lavorato a mano libera in una direzione sentimentale: Alberto e Thomas sono due anaffettivi capaci di esprimersi solo attraverso l’organigramma delle predilezioni culturali, che possono essere spassose, ma raccontano l’inerzia di una psicologia incagliata. Motoko è una donna in crisi che sta cercando di comprendersi, di afferrare il senso della propria diversità. Lei è la parte del cuore in un libro “di testa”.
-
Il tuo sguardo in prima persona, invece, come si è incontrato o scontrato con quei modelli? Cosa si è aggiunto o sottratto all’indomani del tuo viaggio in questa terra?
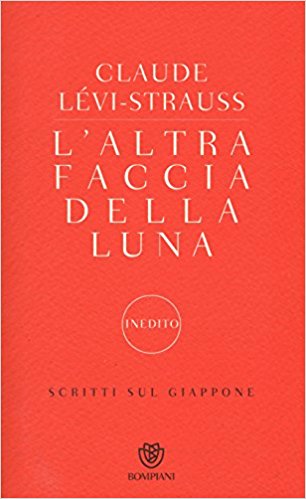 Credo che il Giappone non abbia ancora finito con me. Alcune città entrano spontaneamente nella mitologia privata, anche del viaggiatore più smaliziato. Io non volevo che Tokyo diventasse parte di una mitologia, per questo il “transit” del titolo: per respingere le cose in una dimensione di passaggio, l’unica a cui sentivo di poter attingere con una certa verità. Saprai meglio di me quanto “comprendere il Giappone” sia un’impresa sovrumana. Al più possiamo vivificare l’esperienza per approssimazioni successive, sempre localizzate. Per questo amo la figura del turista, che rappresenta il vero viaggiatore del mondo contemporaneo. Ovvero l’unico possibile, se pensi a come è fatto oggi il mondo. Parlo delle declinazioni del “viaggiare”, naturalmente. Sono convinto che un paese lo conosci più nel profondo quando ti traumatizza, che non quando ti spalanca la sua cultura. C’è tutta una parte di Giappone “global” che mi interessa poco, dal sushi ai manga, ecc. Quel Giappone lì ormai è ovunque. La giapponese cinquantenne, passabilmente ubriaca, che molla i freni inibitori davanti a un ragazzo di colore, passabilmente furbo, in un locale meticcio di Roppongi la trovo più affascinante. Cioè vorrei seguirla fino alla fine della serata. E se non ci riesco posso sempre immaginarmela e sbatterla dentro un romanzo. Non ho compreso a dovere, suppongo, la rigida costruzione dell’autocontrollo e del “decoro” tipicamente giapponesi fin quando non li ho visti venir meno davanti ai miei occhi. È un concetto alla Derrida: la decostruzione dell’impianto sottolinea l’essenza della struttura. Una sera, sulla Yurikamome, tornando da Odaiba, c’era un ragazzo che dormiva a qualche sedile di distanza dal mio. Sai quel sonno da profonda fatica… e insomma questo tipo era lì che dormiva, dondolando con la testa al ritmo del treno. A un certo punto è caduto in avanti e si è spappolato la faccia sul sedile di fronte. Questa scena avrei potuto metterla nel romanzo, ma poi ho deciso di no (anche se c’è un episodio vagamente simile che riguarda un personaggio americano). Faceva parte, quanto esperienza, della preparazione del romanzo. Quella serie di “incontri” come dici tu, che stabiliscono che direzione il romanzo prenderà. Cosa metterai sulla pagina e cosa lascerai fuori. Ecco, questa è la cosa tremenda, a pensarci: ormai parlo di Tokyo, e in genere del Giappone, quasi sempre ragionando o provando a misurare quanto abbiano influito sulla mia prosa. Il che è il risvolto maledetto di un’affermazione di Roland Barthes, per cui il Giappone ti metterebbe «nella condizione di scrivere». E sembra sciocco, adesso, confermare proprio a te, Laura, quanto questo sia vero. Per quanto mi riguarda Tokyo si è letteralmente installata nell’immaginario, e sarà durissimo (probabilmente anche inutile) tentare di rimuoverla. Però ha perduto qualcosa della sua sostanza reale, diventando materia di una riflessione scritta che prosegue anche quando non scrivo.
Credo che il Giappone non abbia ancora finito con me. Alcune città entrano spontaneamente nella mitologia privata, anche del viaggiatore più smaliziato. Io non volevo che Tokyo diventasse parte di una mitologia, per questo il “transit” del titolo: per respingere le cose in una dimensione di passaggio, l’unica a cui sentivo di poter attingere con una certa verità. Saprai meglio di me quanto “comprendere il Giappone” sia un’impresa sovrumana. Al più possiamo vivificare l’esperienza per approssimazioni successive, sempre localizzate. Per questo amo la figura del turista, che rappresenta il vero viaggiatore del mondo contemporaneo. Ovvero l’unico possibile, se pensi a come è fatto oggi il mondo. Parlo delle declinazioni del “viaggiare”, naturalmente. Sono convinto che un paese lo conosci più nel profondo quando ti traumatizza, che non quando ti spalanca la sua cultura. C’è tutta una parte di Giappone “global” che mi interessa poco, dal sushi ai manga, ecc. Quel Giappone lì ormai è ovunque. La giapponese cinquantenne, passabilmente ubriaca, che molla i freni inibitori davanti a un ragazzo di colore, passabilmente furbo, in un locale meticcio di Roppongi la trovo più affascinante. Cioè vorrei seguirla fino alla fine della serata. E se non ci riesco posso sempre immaginarmela e sbatterla dentro un romanzo. Non ho compreso a dovere, suppongo, la rigida costruzione dell’autocontrollo e del “decoro” tipicamente giapponesi fin quando non li ho visti venir meno davanti ai miei occhi. È un concetto alla Derrida: la decostruzione dell’impianto sottolinea l’essenza della struttura. Una sera, sulla Yurikamome, tornando da Odaiba, c’era un ragazzo che dormiva a qualche sedile di distanza dal mio. Sai quel sonno da profonda fatica… e insomma questo tipo era lì che dormiva, dondolando con la testa al ritmo del treno. A un certo punto è caduto in avanti e si è spappolato la faccia sul sedile di fronte. Questa scena avrei potuto metterla nel romanzo, ma poi ho deciso di no (anche se c’è un episodio vagamente simile che riguarda un personaggio americano). Faceva parte, quanto esperienza, della preparazione del romanzo. Quella serie di “incontri” come dici tu, che stabiliscono che direzione il romanzo prenderà. Cosa metterai sulla pagina e cosa lascerai fuori. Ecco, questa è la cosa tremenda, a pensarci: ormai parlo di Tokyo, e in genere del Giappone, quasi sempre ragionando o provando a misurare quanto abbiano influito sulla mia prosa. Il che è il risvolto maledetto di un’affermazione di Roland Barthes, per cui il Giappone ti metterebbe «nella condizione di scrivere». E sembra sciocco, adesso, confermare proprio a te, Laura, quanto questo sia vero. Per quanto mi riguarda Tokyo si è letteralmente installata nell’immaginario, e sarà durissimo (probabilmente anche inutile) tentare di rimuoverla. Però ha perduto qualcosa della sua sostanza reale, diventando materia di una riflessione scritta che prosegue anche quando non scrivo.
-
Nello specifico quale lavoro di ricerca sostiene la tua conoscenza di Tokyo che riversi nel romanzo? Quali libri consiglieresti per addentrarsi nel suo tessuto narrativo? Quali per approfondire la sua letteratura (Murakami Haruki, da quanto suggerisci alla fine del libro, è volutamente escluso – benché citandolo per negazione doppiamente incluso -: perché?)
Negli ultimi anni ho messo su una sezione della mia biblioteca dedicata al Giappone, una cinquantina di titoli. Ci trovi un po’ di tutto: da Giancarlo Calza, Stile Giappone, che ormai in Italia è un classico, a Elise K. Tipton, altro studio sul Giappone moderno uscito da Einaudi, e Chie Nakane, La società giapponese, da Raffaello Cortina, piuttosto succinto, di facile orientamento. Su Ruth Benedict e Il crisantemo e la spada. Modelli di cultura giapponese, nella nuova edizione Laterza, ho scritto qualche mese fa qui, per Alfabeta2. Molto belle le note di Lévi-Strauss in L’altra faccia della luna, che contiene ricordi e riflessioni dei suoi viaggi giapponesi e quelle di Cees Nooteboom in Cerchi infiniti. Viaggi in Giappone, un collage uscito quest’anno da Iperborea. Nooteboom ha un tocco speciale nel descrivere il Sol Levante, grande sensibilità e il passo dello scrittore raffinato. Un libro a cui sono molto affezionato è Ore giapponesi di Fosco Maraini (Corbaccio): da tutt’altra parte, ma estremamente godurioso, quello di Will Ferguson, Autostop con Buddha, Feltrinelli, che racconta – come da titolo – un lungo viaggio in autostop per il paese. Il libro che più mi ha influenzato per le atmosfere di Tokyo transit è forse Generazione otaku. Uno studio della postmodernità, (Jaca Book) di Azuma Hiroki, un filosofo “irregolare” che si è formato all’Università di Tokyo – in particolare per il concetto di “animalizzazione” che sviluppa nel libro e per la riflessione molto persuasiva sulle subculture giapponesi. Per il cinema: da Marsilio il volumone di Maria Roberta Novielli, Storia del cinema giapponese e un librino agilissimo di Max Tessier dallo stesso titolo, per Lindau. Nel 2015, mentre iniziavamo l’editing di Tokyo transit sono usciti i Quaderni giapponesi di Igort, volume bellissimo di Coconino Press, e per Canicola il Viaggio a Tokyo di Vincenzo Filosa, un gekiga italiano che mi ha molto colpito per come racconta l’attrito tra la mentalità italiana e quella giapponese, in uno spazio poco raccontato come quello del lavoro. Quanto alla narrativa, si aprirebbe una questione a parte: il Giappone ci ha dato scrittori giganteschi, la triade Mishima-Tanizaki-Kawabata (di Kawabata La banda di Asakusa è uno dei romanzi giapponesi che più mi stanno a cuore, per una serie di motivi che sarebbe troppo lungo elencare qui. Qualche anno fa mi sono finalmente impadronito del Millennio del Genji Monogatari, leggerlo è un’esperienza di pura lussuria estetica. Un altro libro che considero importante è Mille anni di piacere di Nakagami Kenji, (Einaudi) scrittore burakumin che racconta storie universali di povertà e disagio, talmente assolute che il Giappone ci entra giusto di scorcio, tra le leggende e i nomi dei personaggi (ed è bello che questa universalità sia raggiunta da uno scrittore venuto fuori da una minoranza emarginata). Tra i contemporanei Murakami Ryū l’ho conosciuto prima come regista della versione cinematografica del suo Tokyo Decadence, poi come scrittore, il suo influsso nella rappresentazione occidentale di un Giappone “estremo” è chiaro e riconosciuto. Sul cinema mi taccio, altro argomento sterminato, anche se – paradossalmente – uno dei film memorabili degli ultimi anni è un collettivo di tre autori non giapponesi del 2008 intitolato Tokyo!, in particolare il primo episodio, per la regia di Michel Gondry, Interior design, che racconta la trasformazione di una ragazza in una sedia, e la conseguente felicità di aver trovato finalmente il proprio posto nel mondo… E vengo alla spinosa questione Murakami Haruki. Murakami è uno scrittore che considero molto lontano dalla mia idea di letteratura, ciononostante ne apprezzo le doti indiscutibili, però a volte mi sembra di sentire sulla sua pagina qualcosa che gira a vuoto, in uno spazio dove l’invenzione domina sulla necessità. Mario Vargas Llosa ha definito qualche anno fa questa mia sensazione con parole più incisive: uno scrittore che ha «ceduto alla letteratura light». Ecco, quell’aggettivo, “light”, conteneva una fronda di sfumature che là per là mi erano sembrate poco chiare, eppure in qualche modo mi convincevano. A volte Murakami mi appare come uno scrittore “difficile”, per cui mi sento addirittura impreparato ad affrontare una sua pagina o una porzione di arco narrativo, eppure è uno degli autori più letti nel nostro paese (nonché al mondo). Questo fatto mi insospettisce. Non capisco se sono io che cerco in Murakami qualcosa che a tutti gli effetti non c’è, o se per caso non sia il vastissimo stuolo dei suoi estimatori ad averlo frainteso. Di sicuro Murakami sa trasmettere un’incomparabile impressione di profondità, però non riesco a considerare certe sue scelte narrative, certe irruzioni dell’onirico, certe casualità improvvise che smuovono le sue storie – e il modo in cui le racconta – senza che si inneschi un cortocircuito con la vicenda letteraria di quello che fino a qualche decennio fa era considerato uno dei nostri massimi poeti, Salvatore Quasimodo, oggi largamente ridimensionato, e al giudizio di Giuseppe De Robertis su Oboe sommerso: «una finzione di profondi sensi, che diventano nonsensi». Dico questo con le dovute cautele e consapevole dell’abnormità di un paragone che vuole soltanto illustrare il mio particolare cortocircuito (anche se “oboe sommerso” potrebbe essere un titolo, o l’elemento di un titolo, alla Murakami). E insomma sospetto che Murakami non sia veramente all’altezza dei grandissimi a cui viene spesso accostato, per esempio Philip Roth, per il quale invece metto allegramente e reiteratamente la mano sul fuoco. Lo so, la letteratura non può ridursi a questione di classifiche – non deve – però a volte certi libri trasmettono proprio questo: l’impressione di un talento sterminato che chissà perché si mette a girare attorno alla facilità (Franzen post-Correzioni, tanto per fare un esempio).
-
Esistono varie visioni di Tokyo. Frequente è lo sguardo dell’occidentale ammaliato, o diversamente sgomento, dall’ordine, dalla pulizia, dallo stretto controllo sociale. Lo straniero, colui che in primis ama sottolineare il termine gaijin molto più di quanto non faccia il giapponese contemporaneo, la vive come un perenne inganno. Perché secondo te?
Forse lo straniero che arriva in Giappone è il primo a “rifiutare l’altro”. C’è il fatto che noi europei abbiamo messo a punto un sistema di valori in cui la creatività, per esempio, è posta molto in alto su un asse verticale, mentre in Giappone la creatività, il laboratorio delle idee, in molti campi, è appannaggio dei sottostrati, delle subculture. Se ci pensi, anche la società americana, che ha un sistema scolastico più rigido di quello italiano e soprattutto meno tollerante con le personalità fuori-norma, nonché un sistema universitario particolarmente vincolante, deve molto all’apporto della cultura underground. La situazione, mi sembra, è che soprattutto agli occhi di un visitatore europeo, post-romantico, post-decadente, un sistema come quello giapponese deve apparire spiccatamente occlusivo o limitativo. La frase nel mio libro pronunciata dal buttadentro di colore me la sono sentita dire per davvero una notte a Roppongi: «Your’re smart, you’re smart because you’re a criminal». Non voglio dare un giudizio superficiale o aprire per colpa di una frase l’intera scatola sociologica, però l’equivalenza pressoché immediata fra un tipo “sveglio” e un criminale, espressa da un lavoratore “esterno” di un settore presumibilmente aperto come lo “svago”, fa pensare. Detto questo, basta guardare alla storia politica e alla durata media dei governi, per comprendere quanto fra Italia e Giappone esistano somiglianze notevoli. Ma immagino che ormai la visione a cui ti riferisci tu sia diventata un cliché globalizzato (penso a film come L’ultimo samurai). Come spiego anche in Tokyo transit, lo “straniero sbucato dal nulla” è un archetipo pauroso: nel libro quello straniero è il cognato di Alberto, che arriva e fa man bassa di tutto – in verità il primo straniero sbucato dal nulla è Edipo, e sappiamo che razza di tragedia dovrà scatenare il suo arrivo in città. Forse gli occidentali in genere sono convinti, o sono stati convinti, che i giapponesi vedano in loro – in ognuno di loro – il seme di una tragedia a venire. Il che, da un punto di vista mitopoietico, è anche verosimile.
-
Cosa ispira secondo te il Giappone oggi, nello specifico in Italia dove pare vivere un vero e proprio boom di interesse? È ancora il luogo di perdizione e/o di indecifrabilità cui lo ricollega lo straniero?
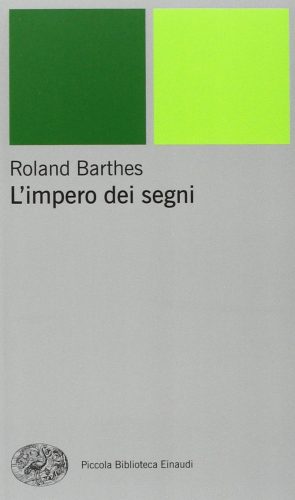 Ci pensavo l’altro giorno aspettando le domande di questa intervista. Come sai ero a Disneyland Paris con le mie figlie, e mi dicevo: be’, non sembra più il nonluogo di Marc Augé (Disneyland e altri nonluoghi, Bollati Boringhieri). Il fatto è che forse ormai esistono più nonluoghi che luoghi. Cioè il nonluogo è stato inglobato definitivamente nella nostra cultura sociale e ha perduto, almeno in parte, la sua carica straniante. Per certi versi è merito della globalizzazione. Nel 1986 sono andato a Disneyworld coi miei genitori: era come atterrare sulla luna. Tutto il mondo americano era una specie di altro-pianeta. In The blues Brothers, che è del 1980, c’è una scena in cui la Bluesmobile distrugge un Toys”R”Us: quella scena noi italiani abbiamo potuto metterla a fuoco molti anni più tardi, quando la catena di giocattoli ha cominciato ad aprire le sue filiali. Oggi ogni marchio è ovunque, ma la familiarità apre a mio avviso direzioni inaspettate, per esempio nel senso del “perturbante” freudiano. Qualche giorno fa, prima di partire, raccontavo a una mamma della classe di mia figlia che nell’86 mi ero divertito come un pazzo dentro l’attrazione Pirates of Carribean. Non ci voleva credere, perché nella sua dimensione di “familiarità” l’attrazione dei parchi Disney doveva essere posteriore alla serie di film con Johnny Deep. Invece è il contrario (anche Augé nomina l’attrazione nel suo libro del 1997: la chiama, un po’ beffardo, «il covo dei bucanieri»). Tutto è omogeneo nello spazio globale, e tutto è sottomesso al dominio del “più recente”. Comunque la notizia ha aperto per la mamma in questione il famoso spazio perturbante di Freud: una cosa familiare ci appare improvvisamente estranea, e questo scatena l’inquietudine. Adesso rifletto sull’attenzione che Augé pone ai genitori dei bambini a Disneyland: questi papà muniti di infallibile telecamera, pronti a riprendere tutto quello che viene loro somministrato in conformità alle aspettative. Oggi come oggi (sono passati vent’anni dal libro di Augé) non serve nemmeno andare a Disneyland, chiunque fa lo stesso col cellulare davanti a una porzione di sushi, a uno scorcio qualunque, a un oggetto qualunque. Il Giappone, probabilmente, riesce a fornire una versione dell’esperienza ancora piuttosto straniante, pur mantenendosi all’interno delle pratiche da nonluogo ormai imperative e istituzionalizzate come abitudini sociali (e forse sarebbe meglio dire: social). Tokyo, in particolare, è un non-nonluogo, perché qui la conformità alle aspettative (esempio ovvio: i sampuru allineati nelle vetrine dei ristoranti) è istituita come pratica sociale con netto anticipo sulla conversione della medesima conformità a caratteristica del nonluogo. In termini più semplici: Tokyo è un nonluogo che ci stupisce per la sua anteriorità al concetto di nonluogo. Non so se siamo di fronte a un “nouveau japonisme”, di fatto credo che molti occidentali, e gli italiani hanno un sesto senso per questo genere di cose, guardino al Giappone come a un territorio di inquietudini, perché una variante decisiva di quell’anteriorità che dicevo è percepita (meno che nel passato, forse, ma comunque percepita) come una funzione dell’anticipo: sappiamo che è là il futuro che ci attende. Il nostro futuro… siamo noi ad essere attesi là. È forse questo a deprimerci: lo straniero non può sbucare dal nulla, quando sia “atteso”.
Ci pensavo l’altro giorno aspettando le domande di questa intervista. Come sai ero a Disneyland Paris con le mie figlie, e mi dicevo: be’, non sembra più il nonluogo di Marc Augé (Disneyland e altri nonluoghi, Bollati Boringhieri). Il fatto è che forse ormai esistono più nonluoghi che luoghi. Cioè il nonluogo è stato inglobato definitivamente nella nostra cultura sociale e ha perduto, almeno in parte, la sua carica straniante. Per certi versi è merito della globalizzazione. Nel 1986 sono andato a Disneyworld coi miei genitori: era come atterrare sulla luna. Tutto il mondo americano era una specie di altro-pianeta. In The blues Brothers, che è del 1980, c’è una scena in cui la Bluesmobile distrugge un Toys”R”Us: quella scena noi italiani abbiamo potuto metterla a fuoco molti anni più tardi, quando la catena di giocattoli ha cominciato ad aprire le sue filiali. Oggi ogni marchio è ovunque, ma la familiarità apre a mio avviso direzioni inaspettate, per esempio nel senso del “perturbante” freudiano. Qualche giorno fa, prima di partire, raccontavo a una mamma della classe di mia figlia che nell’86 mi ero divertito come un pazzo dentro l’attrazione Pirates of Carribean. Non ci voleva credere, perché nella sua dimensione di “familiarità” l’attrazione dei parchi Disney doveva essere posteriore alla serie di film con Johnny Deep. Invece è il contrario (anche Augé nomina l’attrazione nel suo libro del 1997: la chiama, un po’ beffardo, «il covo dei bucanieri»). Tutto è omogeneo nello spazio globale, e tutto è sottomesso al dominio del “più recente”. Comunque la notizia ha aperto per la mamma in questione il famoso spazio perturbante di Freud: una cosa familiare ci appare improvvisamente estranea, e questo scatena l’inquietudine. Adesso rifletto sull’attenzione che Augé pone ai genitori dei bambini a Disneyland: questi papà muniti di infallibile telecamera, pronti a riprendere tutto quello che viene loro somministrato in conformità alle aspettative. Oggi come oggi (sono passati vent’anni dal libro di Augé) non serve nemmeno andare a Disneyland, chiunque fa lo stesso col cellulare davanti a una porzione di sushi, a uno scorcio qualunque, a un oggetto qualunque. Il Giappone, probabilmente, riesce a fornire una versione dell’esperienza ancora piuttosto straniante, pur mantenendosi all’interno delle pratiche da nonluogo ormai imperative e istituzionalizzate come abitudini sociali (e forse sarebbe meglio dire: social). Tokyo, in particolare, è un non-nonluogo, perché qui la conformità alle aspettative (esempio ovvio: i sampuru allineati nelle vetrine dei ristoranti) è istituita come pratica sociale con netto anticipo sulla conversione della medesima conformità a caratteristica del nonluogo. In termini più semplici: Tokyo è un nonluogo che ci stupisce per la sua anteriorità al concetto di nonluogo. Non so se siamo di fronte a un “nouveau japonisme”, di fatto credo che molti occidentali, e gli italiani hanno un sesto senso per questo genere di cose, guardino al Giappone come a un territorio di inquietudini, perché una variante decisiva di quell’anteriorità che dicevo è percepita (meno che nel passato, forse, ma comunque percepita) come una funzione dell’anticipo: sappiamo che è là il futuro che ci attende. Il nostro futuro… siamo noi ad essere attesi là. È forse questo a deprimerci: lo straniero non può sbucare dal nulla, quando sia “atteso”.
-
Sono presenti nel libro lunghe e costanti descrizioni di stralci di conversazione sessuale, per così dire. Che ruolo gioca il sesso nel tuo romanzo? In cosa secondo te riesce a spiegare al lettore il mondo di Thomas e Alberto?
Il sesso è un territorio straordinario e pericolosissimo, in un romanzo. Straordinario perché consente un accesso privilegiato all’intimità dei personaggi, pericolosissimo perché devi scegliere la maniera giusta per raccontarlo. La polarità che solitamente viene tirata in ballo è quella tra allusione e tecnicismo, io volevo per la mia storia un sesso inerte, prevalentemente fallimentare, strozzato, che rispondesse e soprattutto amplificasse le caratteristiche dei miei personaggi. E poi volevo una visione sessualizzata della città (le «linee vulvari del National Gymnasium di Yoyogi»). Tokyo è una città, come notava Barthes, al cui centro c’è un vuoto, e in quel vuoto, la residenza imperiale, se ne sta acquattato il potere (o quantomeno la sua garanzia). Quando penso alla famiglia imperiale segregata là dentro, penso a un centro legato, confinato, a un potere depresso. Ho provato a rappresentare la depressione del sesso – non l’aspetto “triste” dell’animale post-coitum, ma appunto un potere che non riesce a trovare sfogo o soddisfazione. Scrivere il sesso è stata una delle sfide più impegnative con Tokyo transit, volevo un tanto di sarcasmo senza irrisione, volevo intellettualizzare la faccenda, per aumentare la sensazione di inerzia, ma senza scendere fino alla parodia. In alcuni passaggi mi sembra di esserci riuscito, in altri forse meno, però sono rimasto sempre fedele al mio intento principale: rendere il sesso un momento filosofico, nel senso, come dici anche tu, che attraverso il sesso puoi comprendere la visione del mondo dei vari personaggi. Ho affidato la strategia ad alcune metafore e similitudini particolarmente “fredde”, per esempio nel caso della repulsione di Motoko per la penetrazione: «sarebbe stato come inserire barre di cadmio in un reattore nucleare». Tutta la direttrice sessuale del libro procede verso una sterilità trionfante. Più felice il sesso cosmico, le «ammucchiate» gassose delle supernove, ma semplicemente perché l’universo ha tempi più generosi dei nostri, quanto ad estensione.
-
Tokyo transit è stato candidato al Premio Strega, un riconoscimento che da solo vale la definizione di un “brillante esordio”. Cosa significa per te? Chi lo ha amato può attendersi a breve un nuovo romanzo? E l’ambientazione giapponese è casuale o tornerà?
 Quest’anno c’erano grandi libri allo Strega, quattro dei miei preferiti sono entrati in cinquina, in particolare tifavo – ma non era uno schieramento di “genere” – per le due scrittrici, Wanda Marasco e Teresa Ciabatti. Marasco per la prosa ipnotica che riassume le due maggiori tradizioni italiane, lirica e dialetto. Ciabatti perché il libro l’ho trovato talmente fastidioso da non riuscire a scrollarmelo di dosso finché non l’ho terminato, e ho capito che la sua magia stava proprio lì: in quel fastidio persistente, il disagio che provi di fronte a una sincerità smisurata. Quanto a me, è stato piacevole e divertente ritrovarmi – outsider dalla nascita – in un parterre come quello dello Strega. Mi ha confortato molto vedere che il mio libro veniva apprezzato per lo stile, significava che avevo scelto una direzione giusta, e niente ti appartiene quanto lo stile. Al momento sto lavorando a due libri diversi, che scrivo da un po’ di tempo. Non credo che li vedremo prima del 2019. Uno è un romanzo ambientato fra Roma e Milano che racconta l’ultimo – folle – tentativo di riscatto di uno sceneggiatore televisivo la cui vita sta andando beatamente in frantumi. L’altro è un “tropicario” in cui racconto quindici anni di viaggi: la mia versione di alcuni presunti paradisi tra Oceano Indiano, Emirati Arabi, Polinesia Francese, Africa, Australia… e vorrei concluderlo con un’ultima spiaggia che ancora manca all’appello: Okinawa – cosa che, come puoi immaginare, mi costringerà a tornare in Giappone per i “necessari rilievi”.
Quest’anno c’erano grandi libri allo Strega, quattro dei miei preferiti sono entrati in cinquina, in particolare tifavo – ma non era uno schieramento di “genere” – per le due scrittrici, Wanda Marasco e Teresa Ciabatti. Marasco per la prosa ipnotica che riassume le due maggiori tradizioni italiane, lirica e dialetto. Ciabatti perché il libro l’ho trovato talmente fastidioso da non riuscire a scrollarmelo di dosso finché non l’ho terminato, e ho capito che la sua magia stava proprio lì: in quel fastidio persistente, il disagio che provi di fronte a una sincerità smisurata. Quanto a me, è stato piacevole e divertente ritrovarmi – outsider dalla nascita – in un parterre come quello dello Strega. Mi ha confortato molto vedere che il mio libro veniva apprezzato per lo stile, significava che avevo scelto una direzione giusta, e niente ti appartiene quanto lo stile. Al momento sto lavorando a due libri diversi, che scrivo da un po’ di tempo. Non credo che li vedremo prima del 2019. Uno è un romanzo ambientato fra Roma e Milano che racconta l’ultimo – folle – tentativo di riscatto di uno sceneggiatore televisivo la cui vita sta andando beatamente in frantumi. L’altro è un “tropicario” in cui racconto quindici anni di viaggi: la mia versione di alcuni presunti paradisi tra Oceano Indiano, Emirati Arabi, Polinesia Francese, Africa, Australia… e vorrei concluderlo con un’ultima spiaggia che ancora manca all’appello: Okinawa – cosa che, come puoi immaginare, mi costringerà a tornare in Giappone per i “necessari rilievi”.

