Della mediazione e dei treni giapponesi
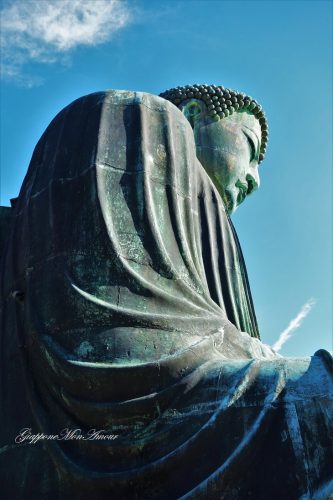 Mi alzo due volte, con estrema fatica. Ma conosco quell’altra fatica, di tirarsi dietro una vita che oltretutto, non sempre si aggiusta ai ritmi del corpo ospitante. Il ricordo della gravidanza è recente, i segni li ritrovo nello specchio durante la doccia, nei lombi che paiono cartapesta.
Mi alzo due volte, con estrema fatica. Ma conosco quell’altra fatica, di tirarsi dietro una vita che oltretutto, non sempre si aggiusta ai ritmi del corpo ospitante. Il ricordo della gravidanza è recente, i segni li ritrovo nello specchio durante la doccia, nei lombi che paiono cartapesta.
L’azienda giapponese di messaggistica istantanea LINE si è inventata un’applicazione per permettere a chi è incinta e desidera sedersi, e a chi siede ed è disponibile a cedere il posto ma vorrebbe farlo con discrezione, senza sbracciarsi, di comunicare a bordo dei treni. Si inserisce la propria posizione nella carrozza, il sedile occupato, per dire il secondo dal fondo. Spiega tutto in dettaglio un servizio alla tv.
«Mi vergogno a rivolgere la parola sul treno» confessa un giovane salaryman. «Vorrei cedere il posto, ma a volte è complicato»
«Non mi piace dover attirare l’attenzione mostrando la pancia o il simbolino attaccato alla borsa» lamenta una donna con un bimbo piccolo in braccio.
Nelle due gravidanze trascorse dal principio alla fine in Giappone è stato francamente difficile conciliare l’immagine di un popolo tanto garbato e generoso, con la mancanza pressoché totale di offerta del posto, neppure nelle aree riservate del convoglio.
Ho cercato ragione nella percezione del treno, che per i giapponesi è il prolungamento della propria casa, e ogni orario è spesso studiato millimetricamente al fine di trascorrere una crociera serena, sedersi e recuperare un poco di sonno, concludere una bracciata di lavoro, l’estremo ripasso per l’esame del giorno. Possibile attenuante sta anche nel fatto che i treni sono tanti e a intervalli così ravvicinati che si può riuscire, a propria volta, a pianificare un viaggio che schivi gli orari di punta, il congestionamento di certe tratte. Tuttavia resta il fatto che il posto non viene ceduto. Che una donna incinta che si ritrova su un treno affollato, ha poche speranze di vedersi aprire uno spazio a sedere.

Ed ecco dove si inserisce, in questa fessura di indugio, nel tentennamento dell’intenzione irrealizzata, la applicazione del cellulare che segnala il treno su cui si salirà, il bisogno a seconda, la disponibilità.
Mi stupisco di come l’immediatezza di un «Prego, si segga» risulti di gestione complessa, di come il meglio di sé sia avvolto (fino quasi a risultare nascosto) da un ineffabile senso di vergogna.
Non sono solita dare giudizi, trovo molto più arricchente cercare i motivi, tanto più quando lontani da me e dal mio modo di agire. Difatti non giudicherò, il “bene” e “male” sono due concetti che da sempre sospetto.
 Eppure confesso che, nella pratica, condividere dati al cellulare, ritrovarsi a fare un cenno di intesa basata su uno scambio già avvenuto in rete, esplicitare insomma l’intenzione in modo palese tramite un’applicazione, mi risulterebbe francamente più intimo di un estemporaneo gesto di gentilezza.
Eppure confesso che, nella pratica, condividere dati al cellulare, ritrovarsi a fare un cenno di intesa basata su uno scambio già avvenuto in rete, esplicitare insomma l’intenzione in modo palese tramite un’applicazione, mi risulterebbe francamente più intimo di un estemporaneo gesto di gentilezza.
Mi pare si abbia bisogno di sempre più mediatori per esprimerci al meglio.
Tuttavia mi affascina l’avviluppata anima di chi ricopre di segni il proprio sentire, l’anima stretta stretta in una ragnatela di azioni che spostano altrove il fulcro dell’attenzione: a evitare il disturbo, l’imbarazzo, tutto quanto esula dal proprio controllo.
E mi domando se, nell’errore di credere meno intimo questo patto silente di desideri espressi in punta di dita, non scaturisca comunque la bella sorpresa di avvertire meno freddo il cappotto d’umanità che ci circonda.
Il mezzo e il fine. Machiavelli, nella complessità semplificata del suo Il principe, continua dopo cinquecento anni ad avere ragione.




