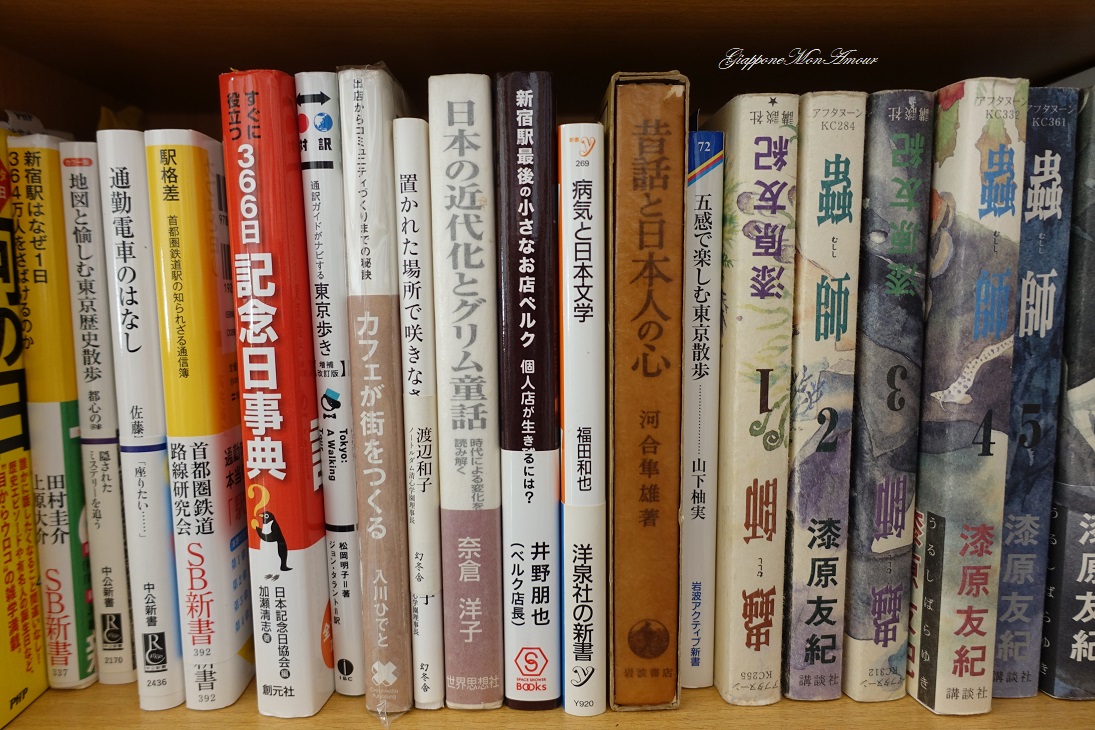Augurare il meglio a chi ci vuole male
L’augurio è, secondo la storia della cultura occidentale, il «responso divinatorio reso dagli àuguri | Rito con il quale si ricavava tale responso». E poi è «segno, presagio, di cosa futura. Presentimento» e anche «speranza, voto di felicità, salute, benessere e sim.».
In giapponese è: negau 願う che è anche la preghiera e secondo l’interpretazione del kanji del prof. Shirakawa una parte indicherebbe una “grande testa” e l’altro il “pensare”, nella cui addizione viene fuori il “pensare a fondo, con profondità”.
 E in questo senso, augurare il meglio a chi ci preme addosso il suo disagio pare un controsenso.
E in questo senso, augurare il meglio a chi ci preme addosso il suo disagio pare un controsenso.
Tuttavia, l’attitudine positiva (pojitibu) dei giapponesi, mi ha insegnato come il controsenso stia piuttosto nell’augurare del male a chi detestiamo. In buona sostanza, questo atteggiamento ci condanna:
1) ad avere quel qualcuno sempre presente nella testa – rinnovando il malessere che proviamo nel ricordare il torto subito;
2) a creare del nuovo disagio in noi – immaginare sfortuna, sofferenza addosso a un altro (sia pure qualcuno che detestiamo) porta un brevissimo piacere, ma lascia spazio alla bruttezza (che rimane dentro chi la concepisce).
 Non so cosa sia scattato in me. Forse il secondo figlio, che mi ha tolto il tempo di rimuginare, o forse l’aumento significativo del lavoro di scrittura, che mi porta immensa felicità e insieme un restringimento ulteriore del giorno (per fare quel che voglio fare, come lo voglio fare, un giorno non basta).
Non so cosa sia scattato in me. Forse il secondo figlio, che mi ha tolto il tempo di rimuginare, o forse l’aumento significativo del lavoro di scrittura, che mi porta immensa felicità e insieme un restringimento ulteriore del giorno (per fare quel che voglio fare, come lo voglio fare, un giorno non basta).
La risposta mi era da sempre davanti, la pronunciavo, ma non riuscivo a convincermene fino in fondo. Forse perché da brava italiana ho sempre avuto una altissima considerazione delle mie emozioni, anche le peggiori: della gelosia “perché significa che davvero tieni a una persona”, della rabbia “perché vuol dire sfogarsi”, dello sfogo “che fa bene, anzi è necessario, sennò come ti alleggerisci?”, dell’appiccicume “perché se non ti senti ogni giorno con un amico o con l’amato, l’affetto cos’è?”.
Il fatto che, in fin dei conti, queste emozioni portassero sofferenza a me o ad altri, lo giustificavo dicendomi che “il sentimento è quanto rende tale un essere umano”, che ogni passione ha due facce, e che quella positiva non c’è verso venga via senza quella negativa.
Sbagliavo.
La risposta è proprio l’indifferenza, mushi suru 無視する.
Ho imparato a valutarla, a distinguere l’indifferenza vera da quella di facciata – che, in sostanza, è una sua negazione, perché capita la si “organizzi” solo al fine di far scattare una reazione in chi la subisce (“io lo ignoro, e lui se ne dispiace”). L’indifferenza cui serve allenarsi (sì, allenarsi!) non ci svuota e non nega le nostre emozioni, ma ha come obiettivo quello di spostare energie e creare spazio per quanto conta di più. Il tempo è poco, il cuore spesso trafficato.
Più profondamente si riesce a provare indifferenza, più essa fornisce libertà d’azione (non si è più vincolati all’emozione fuori controllo) e lucidità di pensiero (quando si agisce, si sa fondamentalmente perché lo si fa).
E praticamente? Cosa significa, quindi?
Ecco, significa ad esempio resistere alla tentazione di andare a cercare informazioni su quella persona. Cosa che, nell’era digitale, pare faccenda complessa. Eppure una volta che te lo vieti, e non rompi la regola (devi metterti in testa che basta anche una sola volta e tutto il lavoro precedente si azzererà), quell’elusione diventa un’abitudine robusta. Naturalmente i passi non andranno più là.
Se non le pensi, le persone non esistono più.
L’irrisolvibile va lasciato là. E se qualcuno si è messo in testa di odiarti, ti basta non dargli volto o voce perché venga automaticamente a morire.
La risposta migliore è, a tutti gli effetti, la felicità.
Non solo la propria – e qui sta forse l’epifania – ma anche quella di chi vorremmo “maledire”.
 Una persona che è felice di solito è impegnata, impegnata nella propria felicità.
Una persona che è felice di solito è impegnata, impegnata nella propria felicità.
La gioia è una sorta di lavoro che ti occupa le mani o la testa, o tutti e due.
Ikari 怒り “la rabbia” invece corrode. C’è il cuore, c’è una donna, c’è un ancora. Cos’è?
Noto personalmente come spesso lo “sfogarsi” corrisponda a un “affogarsi”, perchè le parole hanno un potere enfatizzante, e nel costruire una storia da raccontare, nel riferire quanto ingiusta o meschina sia stata quella persona, la lucidità la perdo mano a mano che recupero dettagli insignificanti (sapessi il tono di voce, mentre parlava mi guardava così, guarda che email disgustosa mi ha inviato, mi sono sentita così in collera).
Anche persone che non valgono niente, nello sfogo diventano enormi.
Così ora, quando mi imbatto in qualcuno di particolarmente fastidioso o, semplicemente, lo recupero nel ricordo, mi dico che bisogna sperare che ottenga un lavoro più soddisfacente, che trovi un amore più luminoso, che scopra una fonte d’appoggio, una consolazione più netta.
Solo così, davvero, smetterò di sentirne parlare.